|
liguria@francobampi.it
[ Indietro ]
Risorgimento tra retorica, finzione e rigurgiti neoborbonici
di Romano Bracalini
Versione in
pdf
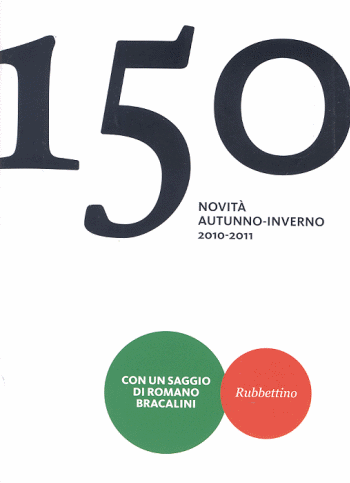 Quando
comincia e finisce il Risorgimento? Il quesito non dev’essere secondario se
gli storici ancora ne discutono senza giungere a un risultato univoco e condiviso.
In Francia il 1789 segna l’inizio della grande Rivoluzione; il 1776 è l’anno della
Dichiarazione d'indipendenza americana. Non ci sono dubbi sul loro significato
fondativo. In Italia, invece, anche per le celebrazioni del 150° dell'unità, i
pareri continuano ad essere discordi e contraddittori. Solitamente si fa coincidere
la conclusione del processo unitario con la proclamazione del regno d’Italia, nel
1861, ma tenuto conto che mancano ancora Roma e Venezia c’è chi preferisce posticipare
la data al 1870, quando il “plebiscito tenuto a Roma parve porre un suggello più
definitivo al processo di unificazione nazionale”; ma non manca una interpretazione
in chiave nazionalistica che chiude il ciclo storico con la prima guerra mondiale
(spacciata per quarta guerra di indipendenza) quando l’Italia con Trento e Trieste
completa l’unità territoriale. Più difficile ancora trovare un accordo sulla data
di inizio. Se è vero che è con la rivoluzione europea del 1848 che il processo
unitario si mette in moto, parecchi storici hanno adottato come data d'inizio
il 1815 (Congresso di Vienna), altri il 1796 quando sotto l'influenza francese
comincia ad affermarsi lo spirito di nazionalità che è alla base della predicazione
mazziniana. E tuttavia non passarono molti anni che si dovette ammettere che gran
parte degli obiettivi erano stati falliti. “Se questa è l’Italia, era meglio non
averla fatta”, diceva Sidney Sonnino. Ci si avviava a celebrare il 150° nel solito
clima enfatico e teatrale, così conforme al carattere italiano, quando il
revanscismo neoborbonico e certa libellistica a sensazione hanno riproposto
la questione Nord-Sud come cruciale e che più che mai divide il paese. Cosi
alle spinte centrifughe del Nord, cominciano a corrispondere analoghe rivendicazioni
“etniche” dal Mezzogiorno. Il fatto è che la questione meridionale al momento
dell’unificazione venne sottovalutata. Si preferì “costruire” il mito dell’Italia
unita, che non era mai esistita. Così per risvegliare la vena inaridita degli
italiani, la letteratura romantica, da Massimo D’Azeglio a Tommaso Grossi, recuperò
nel confuso repertorio del passato leggende di nobili cavalieri che difendono
l’onore nazionale offeso e storie edificanti in cui rifulge l’eroismo italiano.
Edmondo De Amicis, il più fantasioso di tutti, racconta le guerre di indipendenza
ad uso degli scolari come la prova della volontà di redenzione di un popolo
dimenticando di dire che le ultime due campagne furono vinte grazie ai francesi
e ai prussiani e che la prima combattuta dai soli piemontesi fu persa ignominiosamente.
Era questa l’Italia che Mazzini voleva tornasse a primeggiare. È forse per questo
che il fascismo alla ricerca di eroi leggendari da propinare alla credulità del
pubblico, riservò a Mazzini, benché repubblicano, ma presentato come eroe
protofascista, un posto d’onore nel Pantheon dei padri fondatori, da Dante a
Balilla, a Enrico Toti che lancia la stampella contro il nemico, restando il
mistero, che la retorica nazionale non ha sciolto, come uno storpio potesse
trovarsi in prima linea se non all'unico scopo di fargli compiere un improbabile
gesto di eroismo. La retorica ufficiale s’è inventata parecchi precursori per
dimostrare che il sogno dell’unità veniva da lontano. Riunire la penisola sotto
un'unica casata parve all’imperatore Federico Il, di pura schiatta tedesca,
altrettanto impossibile che “incatenar le nubi”. Dopo di lui, il duca Cesare
Borgia, detto il Valentino, ispiratore del Machiavelli, si sarebbe accontentato
di unificare l’Italia centrale, esclusa la Toscana, omogenea per lingua e cucina,
ovvero l’Italia della “porchetta e del brodetto”, quella che va da Roma alle
Marche e all’Umbria, futuro Stato Pontificio. Napoleone I, benché poco rispettoso
della sovranità dei popoli, concepì le due Cisalpine, con la repubblica italiana
(1802) e infine il regno d’Italia (1805), un vasto regno unificato del Nord,
sotto sovranità francese, con capitale Milano. Il ’48 rimette in discussione
tutto e perfino un fior di reazionario come Carlo Alberto può presentarsi con
l’ambiziosa divisa del “liberatore di popoli”. Ma Carlo Alberto, “L’Italo Amleto”,
è ossessionato dal dubbio. Vado o non vado? E quando si decide a varcare il
Ticino va incontro a una duplice sconfitta, all’esilio, alla morte. Carlo
Alberto, il primo Carignano di gentile aspetto, ma non di acuta intelligenza,
altissimo e malinconico, macera le proprie incertezze nelle pratiche di
religione. I Savoia sono così: bigotti o mangiapreti, troppi alti o troppo
bassi da sfigurare alla leva; mai una misura di equità. Sono purtroppo
i sovrani che ha avuto in sorte l'Italia. Si dice che Carlo Alberto porti
il cilicio ma ciò non gli impedisce di abbandonarsi a scene erotiche
come un detraqué (squilibrato). “Re liberatore”, lo acclama la propaganda
che vuole farne un eroe per forza alla testa del movimento tricolore.
Tiratovi per i capelli, lui ci prova poveretto! Così nel 1848 arrivando
a Milano, a cose fatte, cioè a città liberata dai milanesi, adotta il
tricolore, simbolo repubblicano, derivato dal drapeau francese, e stempera
il significato rivoluzionario mettendo nel bianco della bandiera lo stemma
dei Savoia. S’è mai vista una monarchia giacobina che riesce a conciliare
rivoluzione e diritto divino? I Savoia, per opportunismo e tornaconto, vi
riuscirono, pur restando nell'animo e nelle abitudini dei rozzi vassalli
dei re di Francia. La metamorfosi del re “cittadino” è appena agli inizi.
“Tutti i miei averi, i miei figli, la mia vita stessa per il trionfo della
causa nazionale”. Frase impegnativa che deve essere tradotta perché il re
sabaudo parla solo francese. Fuori dell’angusto e gesuitico Piemonte nessuno
conosce quel re troppo lungo e baciapile che non disdegna le gonnelle. Così
la sincerità della causa che dice di voler difendere sembra piuttosto dubbia
oltre che di recentissimo conio. Ed è la propaganda ad amplificare il nobile
messaggio; ma i primi a non crederci sono i liberali che egli ha così spesso
tradito. Nel ’21 appoggia i “carbonari”, fa credere d’essere uno di loro e
poi li abbandona alla vendetta del re Carlo Felice, suo zio, ribattezzato
dal popolo angariato Carlo Feroce. Nel ’48, sotto l’incalzare degli avvenimenti
europei, è costretto a concedere lo Statuto, octroye, ossia dall’alto. Dove
sono le felici promesse del futuro regno unitario? Certo, grande senso della
regalità e del prestigio, sebbene ambasciatori e funzionari stranieri descrivano
l’etichetta di corte come la più stucchevole e antiquata d’Europa. Il re che
ha la tristezza scritta sul volto, come una prefigurazione del destino, si
affida al fato e ne fa il suo motto luttuoso: J’attent mon astre, in francese
arcaico, che così bene si adatta alla corte più lugubre d'Europa. E il destino
si compie. Nella guerra del 1848-49, a riprova che i suoi timori non erano
infondati, Carlo Alberto perderà tutto; e solo la generosità di Radetzky
permetterà a suo figlio, diventato re, Vittorio Emanuele, di accettare le
condizioni non troppo onerose per il Piemonte, esposto al pericolo di una
invasione se solo l’Austria l’avesse voluto. Nell'armistizio di Vignale gli
storici di corte descrivono il giovane Vittorio Emanuele in un atteggiamento
sdegnoso, quasi che il vincitore fosse lui, e non il vecchio maresciallo
austriaco che anche in quella occasione darà la misura del suo onore di soldato
e di gentiluomo. Nello svolgimento degli eventi dal 1859 in poi, il diplomatico
e politico francese Adolphe Thiers, futuro presidente della Terza repubblica,
non ravvisava se non la pratica del motto di un principe sabaudo: “L'Italia è
un carciofo che casa Savoia deve mangiare foglia a foglia”, che ben si accorda
con la loro fama di “ladri di terre”. Sotto la regia del conte di Cavour, geniale
e spregiudicato, ma poco conoscitore del mosaico italiano che ha l’ambizione
di voler ricomporre, Vittorio Emanuele stipula un'alleanza politico-militare
col “golpista” Napoleone III, imperatore dei francesi, che ambisce a stabilire
un “protettorato” sulla penisola. In cambio offre il suo aiuto per “liberare”
l’Italia dagli austriaci. Chissà dov’è la differenza! La campagna del ’59, a
lungo preparata, avrà un brusco epilogo. Nizza e Savoia sono il prezzo del sangue
francese. Il Piemonte avrà la Lombardia che gli austriaci in un supremo atto
di disprezzo hanno ceduto alla Francia. Nelle fasi dell’armistizio di Villafranca
i piemontesi erano rimasti fuori della porta. Cavour fuori di sé era giunto
a minacciare il re gridandogli sul muso: “Voi siete una merda”, detto però
in francese che faceva più fino. Chissà cosa aveva creduto! Il Piemonte era
un piccolo stato militarista ma non era la Prussia. Il 1859-60 è il biennio
decisivo. La Sicilia, il Mezzogiorno continentale, l’Italia centrale. Tutto
è rapidamente conquistato. I plebisciti voluti dalla Corona dovrebbero sancire
la volontà popolare che nessuno ha consultato. La storia del nuovo Stato comincia
con un sopruso; per schiacciare la ribellione meridionale ci vorrà un esercito
di invasione e la medesima ferocia dei croati a Milano. Dov'è la differenza?
Cavour, che ha avuto appena il tempo di vedere l’epilogo del suo “capolavoro”,
tutto questo non l’aveva previsto. Del resto oltre Firenze non era mai stato.
Era la prima volta che Nord e Sud si incontravano, o meglio che venivano a
collisione. Una frattura che non sarà più sanata in un secolo e mezzo di storia
unitaria. I costumi e le abitudini non cambiarono dopo il 1861, benché la
propaganda facesse ogni sforzo per decantare la perfetta armonia e i vantaggi
politici ed economici derivati dall’unità. L’ideologia risorgimentale, come
sovente fanno i vincitori, prima che vengano chiamati a rispondere dei loro
fallimenti, bollò gli antichi Stati come peggio non si poteva, allo scopo
evidente di far rifulgere al meglio le qualità della “nuova” Italia. Messo
alla prova, il nuovo regime non si dimostrò migliore dei governi assoluti. In
molti casi si dimostrò infinitamente peggiore e più lontano dalle aspettative
del popolo di quanto non lo fossero stati gli antichi principi. Né venne
assicurata maggiore libertà e giustizia sociale: malcostume, arbitrio e corruzione
continuarono ad allignare esattamente come prima, se non di più. Quanto al
progresso materiale, l’industria e l’agricoltura, specie nel Nord-Ovest, erano
già in stato avanzato molto prima dell’unità e il benessere economico, in
proporzione ai tempi, un dato largamente acquisito grazie alle ferrovie, alle
strade, alle navi a vapore, ai moderni opifici del Centro-Nord. Oggi non solo
la distanza è aumentata tra i due capi della penisola, ma le statistiche
dimostrano che il Nord ha perduto competitività, senza alcun vantaggio per
il Sud che continua a perdere terreno. Alla metà dell'Ottocento Milano era
considerata una delle città più ricche ed eleganti d'Europa. Rispetto alle
città italiane la capitale lombarda continua a mantenere il primato della
ricchezza e della modernità; ma l'eleganza e il senso civico, che avevano
affascinato Stendhal, non sembrano più il tratto distintivo. Quanto è avvenuto
dopo il ’61 non ci sembra di poterlo catalogare sotto la voce “progresso”.
Fin dal suo esordio l’Italia sabauda accentuò il carattere reazionario e
aggressivo con dispendiose e fallimentari avventure coloniali e guerre di
conquista. Al popolo venivano negati i fondamentali diritti costituzionali.
I poveri e gli analfabeti non votavano. Le tasse erano tra le più alte d’Europa.
Il nuovo stato unitario sembrava piuttosto la sommatoria degli antichi Stati,
da cui aveva ereditato solo i lati peggiori e gli antichi vizi di forma:
corporativismo, clientelismo, autoritarismo e nessun barlume di coscienza
nazionale moderna. Ciascuno restava legato alla propria regione, alle proprie
abitudini. Alle manchevolezze e ai lati oscuri sopperivano le “correzioni”
della propaganda. Fatto sta che il Risorgimento venne intriso di troppe leggende,
“menzogne necessarie a tutte le rivoluzioni”, le aveva definite con “rude
franchezza” Ferdinando Martini. Il 150° era l’occasione per un pacato ed
equilibrato bilancio. Invece ha visto il moltiplicarsi di libelli neoborbonici
che, sfruttando le delusioni di quelle popolazioni, hanno descritto il
Mezzogiorno come un Eldorado, prima dell’unità, per far sembrare più insopportabile
e frutto di calcolo di interesse la “conquista”: pure invenzioni fantastiche
che tuttavia il pubblico meridionale, per senso di rivalsa, ha accolto come
verità inconfutabili che non avevano bisogno di dimostrazione. L’inganno è
stato completo. Eppure all’indomani dell’unificazione il quadro era già
abbastanza chiaro circa le differenze e il diverso grado di sviluppo e nessuna
seria statistica avrebbe potuto smentirlo. Ma già allora vi fu chi – per
esempio Francesco Saverio Nitti – aveva tentato di accreditare la leggenda
di un Mezzogiorno, ricco e benedetto da Dio, che di gran lunga sopravanzava
il Nord nell’economia, nel progresso e nello sviluppo civile; e furono Salvemini
e Fortunato a smentire questo quadro d’ottimismo rammentando che nel Mezzogiorno,
tranne qualche breve tratta intorno a Napoli, non v’erano ferrovie, strade,
industrie moderne e l’analfabetismo toccava punte del 90 per cento. L’autore
di queste note ha scritto un libro per l’editore Rubbettino:
Brandelli d’Italia, 150 anni di conflitti Nord-Sud, (domenica 29 maggio 2011: copia sul FBW) allo
scopo di ricomporre minuziosamente, senza preconcetti, i termini della questione,
con tutti gli attori e i protagonisti del dramma (perché di questo si tratta).
Se non servisse a rendere più consapevoli i lettori del Sud sulla necessità di
trovare altre strade e nuove energie e di invertire la rotta, questo libro avrebbe
fallito lo scopo. Ma un fatto è certo: se il Sud continuerà a macerarsi nel
rimpianto sterile e nell’orgoglio ferito, non avrà scampo. La libellistica
neoborbonica, con l’avallo di critici compiacenti, non serve e non aiuta al Sud;
anzi lo danneggia coltivando false illusioni: “Siamo più poveri perché il Nord
ci ha rubato tutte le nostre ricchezze”, è la fola che si sente ripetere. Una
libellistica, sconsiderata e mendace, che sobilla il Sud nel suo secolare complesso.
Accentua il contrasto. Mette gli uni contro gli altri, come avvenne alla fine
dell’Ottocento con Edoardo Scarfoglio, direttore del «Il Mattino», paladino di
Crispi e del Sud, che minacciò di muovere guerra al Nord “sfruttatore”. Ma il
revanscismo neoborbonico è la conseguenza degli errori compiuti. Un paese non
può reggersi sull’inganno e sulla finzione. Così da una parte si ecceduto nella
retorica di un Risorgimento ideale popolato di martiri e di eroi. Cosi dall’altra
si è raccontato che il regno delle Due Sicilie era superiore al Nord; che le
“parti erano invertite” al momento dell’unità, come ha ripetuto anche il governatore
siciliano, Lombardo, sotto l’evidente impressione di cattive letture. Se i
circoli oltranzisti neoborbonici non la raccontano giusta, anzi fanno a brandelli
la storia, nemmeno la storiografia ufficiale s’è dimostrata troppo rigorosa e
rispettosa della verità. Un errore genera l’altro. L’avvento di Roma capitale,
un’altra idea di Cavour, divise ulteriormente il Paese anziché unirlo. Roma non
si dimostrò un felice acquisto se le polemiche sono continuate fino ai giorni
nostri. Veniva rimarcato il suo carattere scettico, irridente e parassitario.
Erano contrari gli spiriti più avveduti che non attribuivano alla nuova capitale
meriti speciali né virtù civiche, anzi ne aveva troppo poche per primeggiare su
città che, bene o male, erano state al passo con la storia. Manzoni avrebbe
preferito Firenze anche per “l'unità della lingua”. D'Azeglio considerava Roma
una “fantasticheria medievale”. L’occasione venne quando, con la guerra
franco-prussiana del 1870, le prime sconfitte costrinsero i francesi a ritirare
il presidio da Roma. La presa di Roma, citata in tutti i manuali fino a farne
un culto, non ebbe nulla di solenne. Il generale Kanzler, comandante delle
truppe pontificie, chiamate dai romani “li caccialepri”, aveva disposto che
i materassi dei suoi soldati, compresi quelli del papa, fossero messi a
protezione dei monumenti e dei palazzi apostolici. Complessivamente vennero
sparati 835 colpi di artiglieria, poi i bersaglieri entrarono di corsa dalla
breccia di Porta Pia accolti dall’indifferenza dei romani. I morti italiani
furono in tutto otto, ma la cifra non venne rivelata subito per dare l’impressione
che i caduti fossero molti di più. L'indomani vennero mandati i fotografi e ai
bersaglieri venne dato l'ordine di gettarsi a terra per “fare il morto”. Con
qualche nostalgia per la grandiosità papale, il grande storico tedesco Ferdinand
Gregorovius scrisse che “Roma perdeva l’atmosfera di repubblica universale per
scadere al rango di capitaluccia degli italiani”. La storiografia ufficiale
impegnata ad esaltare le nuove “conquiste” trascurò il fatto che Stati progrediti
e civili, con codici all’avanguardia, come il regno Lombardo-Veneto, il ducato
di Parma, il granducato di Toscana, i tre stati meglio amministrati della
penisola (non a caso tutti e tre sotto influenza austriaca) dovettero abbandonare
leggi, regole e consuetudini per applicarne altre infinitamente peggiori. Buone
amministrazioni furono sostituite da inefficienti e tiranniche burocrazie, che
ancora oggi ci opprimono, finché Stati, come appunto la Toscana, il primo stato
europeo ad abolire la pena di morte, decaddero fino a perdere ogni primato dopo
aver costituito un modello in tutta Europa. Né il nuovo stato, che voleva
presentarsi come moderno, parve più dinamico ed efficiente. Il teatro la Fenice
di Venezia, distrutto da un incendio nel 1836, venne ricostruito in due anni
dall’amministrazione austriaca descritta dalla propaganda come “tirannica e
retriva”. Magari ci fosse stato un granduca a Venezia quando la Fenice in tempi
recentissimi andò a fuoco un'altra volta! Il teatro avrebbe riaperto più in fretta.
Il sospetto che prese lentamente forma è che gli italiani, portati a combattersi
tra loro, divisi in conventicole come nel Medio Evo, fossero incapaci di
autogovernarsi e che l’interesse personale e di parte avrebbe travalicato quello
collettivo. Non erano pochi gli osservatori stranieri che non si sarebbero
meravigliati se l’esperimento unitario fosse fallito. Vittorio Gorresio su
«La Stampa» del 19 novembre 1972 scriveva che “gli italiani dovevano ricercare
in se stessi le cause di questo fallimento con la riserva che ogni processo
di unificazione ha le sue esigenze costrittive e improvvisatrici che è impossibile
deludere; con l'obiettiva constatazione che in breve giro di anni la pretesa
piemontizzazione dell’Italia si è risolta in una meridionalizzazione effettiva
del nuovo stato unitario tutto intero; e col triste avveramento della profezia
di re Francesco Il di Borbone circa le difficoltà o l’impossibilità “di ogni
governo” in un paese come il nostro”. Quando
comincia e finisce il Risorgimento? Il quesito non dev’essere secondario se
gli storici ancora ne discutono senza giungere a un risultato univoco e condiviso.
In Francia il 1789 segna l’inizio della grande Rivoluzione; il 1776 è l’anno della
Dichiarazione d'indipendenza americana. Non ci sono dubbi sul loro significato
fondativo. In Italia, invece, anche per le celebrazioni del 150° dell'unità, i
pareri continuano ad essere discordi e contraddittori. Solitamente si fa coincidere
la conclusione del processo unitario con la proclamazione del regno d’Italia, nel
1861, ma tenuto conto che mancano ancora Roma e Venezia c’è chi preferisce posticipare
la data al 1870, quando il “plebiscito tenuto a Roma parve porre un suggello più
definitivo al processo di unificazione nazionale”; ma non manca una interpretazione
in chiave nazionalistica che chiude il ciclo storico con la prima guerra mondiale
(spacciata per quarta guerra di indipendenza) quando l’Italia con Trento e Trieste
completa l’unità territoriale. Più difficile ancora trovare un accordo sulla data
di inizio. Se è vero che è con la rivoluzione europea del 1848 che il processo
unitario si mette in moto, parecchi storici hanno adottato come data d'inizio
il 1815 (Congresso di Vienna), altri il 1796 quando sotto l'influenza francese
comincia ad affermarsi lo spirito di nazionalità che è alla base della predicazione
mazziniana. E tuttavia non passarono molti anni che si dovette ammettere che gran
parte degli obiettivi erano stati falliti. “Se questa è l’Italia, era meglio non
averla fatta”, diceva Sidney Sonnino. Ci si avviava a celebrare il 150° nel solito
clima enfatico e teatrale, così conforme al carattere italiano, quando il
revanscismo neoborbonico e certa libellistica a sensazione hanno riproposto
la questione Nord-Sud come cruciale e che più che mai divide il paese. Cosi
alle spinte centrifughe del Nord, cominciano a corrispondere analoghe rivendicazioni
“etniche” dal Mezzogiorno. Il fatto è che la questione meridionale al momento
dell’unificazione venne sottovalutata. Si preferì “costruire” il mito dell’Italia
unita, che non era mai esistita. Così per risvegliare la vena inaridita degli
italiani, la letteratura romantica, da Massimo D’Azeglio a Tommaso Grossi, recuperò
nel confuso repertorio del passato leggende di nobili cavalieri che difendono
l’onore nazionale offeso e storie edificanti in cui rifulge l’eroismo italiano.
Edmondo De Amicis, il più fantasioso di tutti, racconta le guerre di indipendenza
ad uso degli scolari come la prova della volontà di redenzione di un popolo
dimenticando di dire che le ultime due campagne furono vinte grazie ai francesi
e ai prussiani e che la prima combattuta dai soli piemontesi fu persa ignominiosamente.
Era questa l’Italia che Mazzini voleva tornasse a primeggiare. È forse per questo
che il fascismo alla ricerca di eroi leggendari da propinare alla credulità del
pubblico, riservò a Mazzini, benché repubblicano, ma presentato come eroe
protofascista, un posto d’onore nel Pantheon dei padri fondatori, da Dante a
Balilla, a Enrico Toti che lancia la stampella contro il nemico, restando il
mistero, che la retorica nazionale non ha sciolto, come uno storpio potesse
trovarsi in prima linea se non all'unico scopo di fargli compiere un improbabile
gesto di eroismo. La retorica ufficiale s’è inventata parecchi precursori per
dimostrare che il sogno dell’unità veniva da lontano. Riunire la penisola sotto
un'unica casata parve all’imperatore Federico Il, di pura schiatta tedesca,
altrettanto impossibile che “incatenar le nubi”. Dopo di lui, il duca Cesare
Borgia, detto il Valentino, ispiratore del Machiavelli, si sarebbe accontentato
di unificare l’Italia centrale, esclusa la Toscana, omogenea per lingua e cucina,
ovvero l’Italia della “porchetta e del brodetto”, quella che va da Roma alle
Marche e all’Umbria, futuro Stato Pontificio. Napoleone I, benché poco rispettoso
della sovranità dei popoli, concepì le due Cisalpine, con la repubblica italiana
(1802) e infine il regno d’Italia (1805), un vasto regno unificato del Nord,
sotto sovranità francese, con capitale Milano. Il ’48 rimette in discussione
tutto e perfino un fior di reazionario come Carlo Alberto può presentarsi con
l’ambiziosa divisa del “liberatore di popoli”. Ma Carlo Alberto, “L’Italo Amleto”,
è ossessionato dal dubbio. Vado o non vado? E quando si decide a varcare il
Ticino va incontro a una duplice sconfitta, all’esilio, alla morte. Carlo
Alberto, il primo Carignano di gentile aspetto, ma non di acuta intelligenza,
altissimo e malinconico, macera le proprie incertezze nelle pratiche di
religione. I Savoia sono così: bigotti o mangiapreti, troppi alti o troppo
bassi da sfigurare alla leva; mai una misura di equità. Sono purtroppo
i sovrani che ha avuto in sorte l'Italia. Si dice che Carlo Alberto porti
il cilicio ma ciò non gli impedisce di abbandonarsi a scene erotiche
come un detraqué (squilibrato). “Re liberatore”, lo acclama la propaganda
che vuole farne un eroe per forza alla testa del movimento tricolore.
Tiratovi per i capelli, lui ci prova poveretto! Così nel 1848 arrivando
a Milano, a cose fatte, cioè a città liberata dai milanesi, adotta il
tricolore, simbolo repubblicano, derivato dal drapeau francese, e stempera
il significato rivoluzionario mettendo nel bianco della bandiera lo stemma
dei Savoia. S’è mai vista una monarchia giacobina che riesce a conciliare
rivoluzione e diritto divino? I Savoia, per opportunismo e tornaconto, vi
riuscirono, pur restando nell'animo e nelle abitudini dei rozzi vassalli
dei re di Francia. La metamorfosi del re “cittadino” è appena agli inizi.
“Tutti i miei averi, i miei figli, la mia vita stessa per il trionfo della
causa nazionale”. Frase impegnativa che deve essere tradotta perché il re
sabaudo parla solo francese. Fuori dell’angusto e gesuitico Piemonte nessuno
conosce quel re troppo lungo e baciapile che non disdegna le gonnelle. Così
la sincerità della causa che dice di voler difendere sembra piuttosto dubbia
oltre che di recentissimo conio. Ed è la propaganda ad amplificare il nobile
messaggio; ma i primi a non crederci sono i liberali che egli ha così spesso
tradito. Nel ’21 appoggia i “carbonari”, fa credere d’essere uno di loro e
poi li abbandona alla vendetta del re Carlo Felice, suo zio, ribattezzato
dal popolo angariato Carlo Feroce. Nel ’48, sotto l’incalzare degli avvenimenti
europei, è costretto a concedere lo Statuto, octroye, ossia dall’alto. Dove
sono le felici promesse del futuro regno unitario? Certo, grande senso della
regalità e del prestigio, sebbene ambasciatori e funzionari stranieri descrivano
l’etichetta di corte come la più stucchevole e antiquata d’Europa. Il re che
ha la tristezza scritta sul volto, come una prefigurazione del destino, si
affida al fato e ne fa il suo motto luttuoso: J’attent mon astre, in francese
arcaico, che così bene si adatta alla corte più lugubre d'Europa. E il destino
si compie. Nella guerra del 1848-49, a riprova che i suoi timori non erano
infondati, Carlo Alberto perderà tutto; e solo la generosità di Radetzky
permetterà a suo figlio, diventato re, Vittorio Emanuele, di accettare le
condizioni non troppo onerose per il Piemonte, esposto al pericolo di una
invasione se solo l’Austria l’avesse voluto. Nell'armistizio di Vignale gli
storici di corte descrivono il giovane Vittorio Emanuele in un atteggiamento
sdegnoso, quasi che il vincitore fosse lui, e non il vecchio maresciallo
austriaco che anche in quella occasione darà la misura del suo onore di soldato
e di gentiluomo. Nello svolgimento degli eventi dal 1859 in poi, il diplomatico
e politico francese Adolphe Thiers, futuro presidente della Terza repubblica,
non ravvisava se non la pratica del motto di un principe sabaudo: “L'Italia è
un carciofo che casa Savoia deve mangiare foglia a foglia”, che ben si accorda
con la loro fama di “ladri di terre”. Sotto la regia del conte di Cavour, geniale
e spregiudicato, ma poco conoscitore del mosaico italiano che ha l’ambizione
di voler ricomporre, Vittorio Emanuele stipula un'alleanza politico-militare
col “golpista” Napoleone III, imperatore dei francesi, che ambisce a stabilire
un “protettorato” sulla penisola. In cambio offre il suo aiuto per “liberare”
l’Italia dagli austriaci. Chissà dov’è la differenza! La campagna del ’59, a
lungo preparata, avrà un brusco epilogo. Nizza e Savoia sono il prezzo del sangue
francese. Il Piemonte avrà la Lombardia che gli austriaci in un supremo atto
di disprezzo hanno ceduto alla Francia. Nelle fasi dell’armistizio di Villafranca
i piemontesi erano rimasti fuori della porta. Cavour fuori di sé era giunto
a minacciare il re gridandogli sul muso: “Voi siete una merda”, detto però
in francese che faceva più fino. Chissà cosa aveva creduto! Il Piemonte era
un piccolo stato militarista ma non era la Prussia. Il 1859-60 è il biennio
decisivo. La Sicilia, il Mezzogiorno continentale, l’Italia centrale. Tutto
è rapidamente conquistato. I plebisciti voluti dalla Corona dovrebbero sancire
la volontà popolare che nessuno ha consultato. La storia del nuovo Stato comincia
con un sopruso; per schiacciare la ribellione meridionale ci vorrà un esercito
di invasione e la medesima ferocia dei croati a Milano. Dov'è la differenza?
Cavour, che ha avuto appena il tempo di vedere l’epilogo del suo “capolavoro”,
tutto questo non l’aveva previsto. Del resto oltre Firenze non era mai stato.
Era la prima volta che Nord e Sud si incontravano, o meglio che venivano a
collisione. Una frattura che non sarà più sanata in un secolo e mezzo di storia
unitaria. I costumi e le abitudini non cambiarono dopo il 1861, benché la
propaganda facesse ogni sforzo per decantare la perfetta armonia e i vantaggi
politici ed economici derivati dall’unità. L’ideologia risorgimentale, come
sovente fanno i vincitori, prima che vengano chiamati a rispondere dei loro
fallimenti, bollò gli antichi Stati come peggio non si poteva, allo scopo
evidente di far rifulgere al meglio le qualità della “nuova” Italia. Messo
alla prova, il nuovo regime non si dimostrò migliore dei governi assoluti. In
molti casi si dimostrò infinitamente peggiore e più lontano dalle aspettative
del popolo di quanto non lo fossero stati gli antichi principi. Né venne
assicurata maggiore libertà e giustizia sociale: malcostume, arbitrio e corruzione
continuarono ad allignare esattamente come prima, se non di più. Quanto al
progresso materiale, l’industria e l’agricoltura, specie nel Nord-Ovest, erano
già in stato avanzato molto prima dell’unità e il benessere economico, in
proporzione ai tempi, un dato largamente acquisito grazie alle ferrovie, alle
strade, alle navi a vapore, ai moderni opifici del Centro-Nord. Oggi non solo
la distanza è aumentata tra i due capi della penisola, ma le statistiche
dimostrano che il Nord ha perduto competitività, senza alcun vantaggio per
il Sud che continua a perdere terreno. Alla metà dell'Ottocento Milano era
considerata una delle città più ricche ed eleganti d'Europa. Rispetto alle
città italiane la capitale lombarda continua a mantenere il primato della
ricchezza e della modernità; ma l'eleganza e il senso civico, che avevano
affascinato Stendhal, non sembrano più il tratto distintivo. Quanto è avvenuto
dopo il ’61 non ci sembra di poterlo catalogare sotto la voce “progresso”.
Fin dal suo esordio l’Italia sabauda accentuò il carattere reazionario e
aggressivo con dispendiose e fallimentari avventure coloniali e guerre di
conquista. Al popolo venivano negati i fondamentali diritti costituzionali.
I poveri e gli analfabeti non votavano. Le tasse erano tra le più alte d’Europa.
Il nuovo stato unitario sembrava piuttosto la sommatoria degli antichi Stati,
da cui aveva ereditato solo i lati peggiori e gli antichi vizi di forma:
corporativismo, clientelismo, autoritarismo e nessun barlume di coscienza
nazionale moderna. Ciascuno restava legato alla propria regione, alle proprie
abitudini. Alle manchevolezze e ai lati oscuri sopperivano le “correzioni”
della propaganda. Fatto sta che il Risorgimento venne intriso di troppe leggende,
“menzogne necessarie a tutte le rivoluzioni”, le aveva definite con “rude
franchezza” Ferdinando Martini. Il 150° era l’occasione per un pacato ed
equilibrato bilancio. Invece ha visto il moltiplicarsi di libelli neoborbonici
che, sfruttando le delusioni di quelle popolazioni, hanno descritto il
Mezzogiorno come un Eldorado, prima dell’unità, per far sembrare più insopportabile
e frutto di calcolo di interesse la “conquista”: pure invenzioni fantastiche
che tuttavia il pubblico meridionale, per senso di rivalsa, ha accolto come
verità inconfutabili che non avevano bisogno di dimostrazione. L’inganno è
stato completo. Eppure all’indomani dell’unificazione il quadro era già
abbastanza chiaro circa le differenze e il diverso grado di sviluppo e nessuna
seria statistica avrebbe potuto smentirlo. Ma già allora vi fu chi – per
esempio Francesco Saverio Nitti – aveva tentato di accreditare la leggenda
di un Mezzogiorno, ricco e benedetto da Dio, che di gran lunga sopravanzava
il Nord nell’economia, nel progresso e nello sviluppo civile; e furono Salvemini
e Fortunato a smentire questo quadro d’ottimismo rammentando che nel Mezzogiorno,
tranne qualche breve tratta intorno a Napoli, non v’erano ferrovie, strade,
industrie moderne e l’analfabetismo toccava punte del 90 per cento. L’autore
di queste note ha scritto un libro per l’editore Rubbettino:
Brandelli d’Italia, 150 anni di conflitti Nord-Sud, (domenica 29 maggio 2011: copia sul FBW) allo
scopo di ricomporre minuziosamente, senza preconcetti, i termini della questione,
con tutti gli attori e i protagonisti del dramma (perché di questo si tratta).
Se non servisse a rendere più consapevoli i lettori del Sud sulla necessità di
trovare altre strade e nuove energie e di invertire la rotta, questo libro avrebbe
fallito lo scopo. Ma un fatto è certo: se il Sud continuerà a macerarsi nel
rimpianto sterile e nell’orgoglio ferito, non avrà scampo. La libellistica
neoborbonica, con l’avallo di critici compiacenti, non serve e non aiuta al Sud;
anzi lo danneggia coltivando false illusioni: “Siamo più poveri perché il Nord
ci ha rubato tutte le nostre ricchezze”, è la fola che si sente ripetere. Una
libellistica, sconsiderata e mendace, che sobilla il Sud nel suo secolare complesso.
Accentua il contrasto. Mette gli uni contro gli altri, come avvenne alla fine
dell’Ottocento con Edoardo Scarfoglio, direttore del «Il Mattino», paladino di
Crispi e del Sud, che minacciò di muovere guerra al Nord “sfruttatore”. Ma il
revanscismo neoborbonico è la conseguenza degli errori compiuti. Un paese non
può reggersi sull’inganno e sulla finzione. Così da una parte si ecceduto nella
retorica di un Risorgimento ideale popolato di martiri e di eroi. Cosi dall’altra
si è raccontato che il regno delle Due Sicilie era superiore al Nord; che le
“parti erano invertite” al momento dell’unità, come ha ripetuto anche il governatore
siciliano, Lombardo, sotto l’evidente impressione di cattive letture. Se i
circoli oltranzisti neoborbonici non la raccontano giusta, anzi fanno a brandelli
la storia, nemmeno la storiografia ufficiale s’è dimostrata troppo rigorosa e
rispettosa della verità. Un errore genera l’altro. L’avvento di Roma capitale,
un’altra idea di Cavour, divise ulteriormente il Paese anziché unirlo. Roma non
si dimostrò un felice acquisto se le polemiche sono continuate fino ai giorni
nostri. Veniva rimarcato il suo carattere scettico, irridente e parassitario.
Erano contrari gli spiriti più avveduti che non attribuivano alla nuova capitale
meriti speciali né virtù civiche, anzi ne aveva troppo poche per primeggiare su
città che, bene o male, erano state al passo con la storia. Manzoni avrebbe
preferito Firenze anche per “l'unità della lingua”. D'Azeglio considerava Roma
una “fantasticheria medievale”. L’occasione venne quando, con la guerra
franco-prussiana del 1870, le prime sconfitte costrinsero i francesi a ritirare
il presidio da Roma. La presa di Roma, citata in tutti i manuali fino a farne
un culto, non ebbe nulla di solenne. Il generale Kanzler, comandante delle
truppe pontificie, chiamate dai romani “li caccialepri”, aveva disposto che
i materassi dei suoi soldati, compresi quelli del papa, fossero messi a
protezione dei monumenti e dei palazzi apostolici. Complessivamente vennero
sparati 835 colpi di artiglieria, poi i bersaglieri entrarono di corsa dalla
breccia di Porta Pia accolti dall’indifferenza dei romani. I morti italiani
furono in tutto otto, ma la cifra non venne rivelata subito per dare l’impressione
che i caduti fossero molti di più. L'indomani vennero mandati i fotografi e ai
bersaglieri venne dato l'ordine di gettarsi a terra per “fare il morto”. Con
qualche nostalgia per la grandiosità papale, il grande storico tedesco Ferdinand
Gregorovius scrisse che “Roma perdeva l’atmosfera di repubblica universale per
scadere al rango di capitaluccia degli italiani”. La storiografia ufficiale
impegnata ad esaltare le nuove “conquiste” trascurò il fatto che Stati progrediti
e civili, con codici all’avanguardia, come il regno Lombardo-Veneto, il ducato
di Parma, il granducato di Toscana, i tre stati meglio amministrati della
penisola (non a caso tutti e tre sotto influenza austriaca) dovettero abbandonare
leggi, regole e consuetudini per applicarne altre infinitamente peggiori. Buone
amministrazioni furono sostituite da inefficienti e tiranniche burocrazie, che
ancora oggi ci opprimono, finché Stati, come appunto la Toscana, il primo stato
europeo ad abolire la pena di morte, decaddero fino a perdere ogni primato dopo
aver costituito un modello in tutta Europa. Né il nuovo stato, che voleva
presentarsi come moderno, parve più dinamico ed efficiente. Il teatro la Fenice
di Venezia, distrutto da un incendio nel 1836, venne ricostruito in due anni
dall’amministrazione austriaca descritta dalla propaganda come “tirannica e
retriva”. Magari ci fosse stato un granduca a Venezia quando la Fenice in tempi
recentissimi andò a fuoco un'altra volta! Il teatro avrebbe riaperto più in fretta.
Il sospetto che prese lentamente forma è che gli italiani, portati a combattersi
tra loro, divisi in conventicole come nel Medio Evo, fossero incapaci di
autogovernarsi e che l’interesse personale e di parte avrebbe travalicato quello
collettivo. Non erano pochi gli osservatori stranieri che non si sarebbero
meravigliati se l’esperimento unitario fosse fallito. Vittorio Gorresio su
«La Stampa» del 19 novembre 1972 scriveva che “gli italiani dovevano ricercare
in se stessi le cause di questo fallimento con la riserva che ogni processo
di unificazione ha le sue esigenze costrittive e improvvisatrici che è impossibile
deludere; con l'obiettiva constatazione che in breve giro di anni la pretesa
piemontizzazione dell’Italia si è risolta in una meridionalizzazione effettiva
del nuovo stato unitario tutto intero; e col triste avveramento della profezia
di re Francesco Il di Borbone circa le difficoltà o l’impossibilità “di ogni
governo” in un paese come il nostro”.
[ Indietro ] |